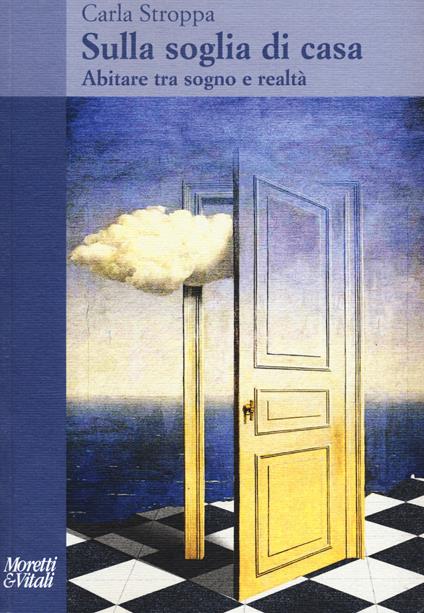Alberto Iannelli
Nel 1950, a Bühlerhöhe, nel Baden-Württemberg, Heidegger tenne un’ormai celebre conferenza, in memoria di Max Kommerell – storico e scrittore svevo già appartenente al circolo letterario di Stefan George e anch’egli studioso di Hölderlin –, dal titolo Die Sprache (Il Linguaggio), pubblica riflessione poi raccolta nell’antologia Unterwegs zur Sprache (In cammino verso il linguaggio), edita nel 1959[1].
La discussione (Erörtern), che aveva per scopo l’accennare a una possibile localizzazione (Ortung) dell’essenza del linguaggio, ci offre pagine su cui davvero esercitare il pensiero che ram-memora (An-denken) e custodisce tanto ri-unendo (Léghein) quanto di-mostrando (Apophàinesthai) o dis-piegando ciò che di-vergendo si dis-volge facendosi innanzi, giacché dis-chiude privilegiato adito alla soglia del Negativo, alla di esso antecedenza fondantiva e al modo autentico o apofatico del darsi ovvero del pro-porsi solo proprio. Parlando del linguaggio, o piuttosto ascoltandolo, egualmente ponendoci in cammino verso il suo dire aurorale, il Negativo, il Destino (Ge-schick), si farà e-vento, presenza, essere, suono e parola, soglia e dolore: Storia (Ge-schichte).
Il linguaggio è connaturato all’uomo e ne riflette la realtà in interdipendenza col pensiero: tanto manifestazione categoriale dell’essenza antropica (zỗon lógos échōn), quanto espressione particolare di una determinata Civiltà (Kultur), prisma che ne veicola l’altrettanto peculiare “visione del mondo” (Weltanschauung), l’animale razione anzitutto parla e parla anzitutto la lingua della propria Comunità storica. Wilhelm von Humboldt e Aristotele perimetrano pertanto, apparentemente, ogni possibile altro dire storico ed eziologico sul linguaggio, ogni possibile localizzazione della sua essenza che non dimori immediatamente ed esclusivamente presso l’orizzonte dell’umano. Nella Metafisica invero, lo Stagirita, nell’ammonire circa l’impossibilità di sostenere e non sostenere indifferentemente errore e verità, giacché, così facendo, nello stesso tempo si compie e non compie asserzione, giudizio, enunciazione di senso, definisce coloro che non sono in grado di formulare apofansi o semplici sintagmi predicativi, indifferentemente pensando e non pensando, loquendo e tacendo, omoíos phytõn. Pensiero, giudizio ed espressione puntellano dunque l’essenza dell’ente semovente-loquente e vi coimplicano la localizzazione dell’essenza del linguaggio stesso.
Nondimeno, pur certamente preconcedendo validità alla relazione bicondizionale che immorsa uomo-e-linguaggio, tale per cui senza l’uomo non vi sarebbe articolazione fonomorfologica alcuna, né tanto meno l’uomo potrebbe essere, dunque sé essere, e non parlare affatto, Heidegger ci ricorda come “resta da riflettere su cosa significhi: l’uomo”.
Ed è proprio rivolgendo la prospettiva che con-rela uomo e linguaggio che, infatti, il pensatore svevo principia questa sua riflessione: l’uomo non parla attraverso il linguaggio, bensì è il linguaggio a parlare, attraverso l’uomo, suo pastore in perenne ascolto con-rispondente. È presso il linguaggio stesso pertanto che occorre con-locare il nostro interrogarne il luogo dell’essenza, per lasciar-essere (sein-lassen) il suo dire iniziante (Sagen) e creativo (Dichtung).
In che modo è e opera il linguaggio come linguaggio? Rispondiamo: il linguaggio parla […]. Il riflettere sul linguaggio esige pertanto che noi ci inoltriamo entro il parlare del linguaggio per prendere dimora presso il linguaggio: nel suo parlare, cioè, e non nel nostro. Soltanto così possiamo raggiungere quel dominio entro cui può riuscire, come può anche non riuscire, che il linguaggio ci riveli la sua essenza. È al linguaggio che va lasciata la parola.
Ma dove, anzitutto, occorre elettivamente volgerci all’ascolto del parlare del linguaggio? Presso ciò che resta, e ciò che resta – è lo stesso dichter Hölderlin a istituirlo – lo fondano i poeti.
Il linguaggio parla. Ma come parla? Dove ci è dato cogliere tale suo parlare? Innanzitutto in una parola già detta. In questa infatti il parlare si è già realizzato. Il parlare non finisce in ciò che è stato detto. In ciò che è stato detto il parlare resta custodito. In ciò che è stato detto il parlare riunisce il modo del suo perdurare e ciò che grazie ad esso perdura – il suo perdurare, la sua “essenza” […]. Se pertanto dobbiamo cercare il parlare del linguaggio in una parola detta, sarà bene, anziché prendere a caso una parola qualsiasi, scegliere una parola pura. Parola pura è quella in cui la pienezza del dire, che è carattere costitutivo della parola detta, si configura come una pienezza iniziante. Parola pura è la poesia.
E la parola pura, la parola che accennerà al farsi E-vento (Ereignis) della Quadratura (Geviert), la parola già detta, la pro-nuncia qui Georg Trakl, in Una sera d’inverno (Ein Winterabend):
Quando la neve cade alla finestra,
A lungo risuona la campana della sera,
Per molti la tavola è pronta
E la casa è tutta in ordine.
Alcuni nel loro errare
Giungono alla porta per oscuri sentieri.
Aureo fiorisce l’albero delle grazie
Dalla finestra linfa della terra.
Silenzioso entra il viandante;
il dolore ha pietrificato la soglia.
Là risplende in pura luce
Sopra la tavola pane e vino.
Wenn der Schnee ans Fenster fällt,
Lang die Abendglocke läutet,
Vielen ist der Tisch bereitet
Und das Haus ist wohlbestellt.
Mancher auf der Wanderschaft
Kommt ans Tor auf dunklen Pfaden.
Golden blüht der Baum der Gnaden
Aus der Erde kühlem Saft.
Wanderer tritt still herein;
Schmerz versteinerte die Schwelle.
Da erglänzt in reiner Helle
Auf dem Tische Brot und Wein.
E-venire all’Ab-senza, presentarsi alla Lontananza
Il nominare, o piuttosto l’e-vocare, il sus-citare, chiama ciò che è chiamato, nella parola, conducendolo presso la presenza della chiamata, ma tale presentazione non distoglie il distante dalla sua lontananza, bensì lo avvicina proprio giacché non-vicino. Senza il nominare, senza il cenno a venire-presso la presenza, il nominato non sopraggiungerebbe mai alla presenza, ossia non si dimostrerebbe mai in essa, non mai epperò ci sarebbe. Nonpertanto, è questo stesso presenziare – egualmente entificare – che consente al chiamato alla presenza di permanere-presso la lontananza dalla presenza.
Ciò significa forse che, ante la chiamata, il chiamato dimorava – già – presso la Non-presenza, ossia nella Lontananza, e che la chiamata fa si che vi per-manga, quasi che senza la chiamata si perderebbe e financo disperderebbe nella Lontananza, allontanandosi da essa? Sia; e, nondimeno, occorre comprendere che cosa significhi sub-sistere – cioè vigere, essere – nella Negazione-della-presenza, e cosa implichi il per-manervi. Dimorava forse – già – come una presenza? Ovvero, dimorava così come esso è e si mostra – dipoi – nella Presenza, in modo che il presenziare ne rappresenti semplicemente una trans-mutazione di luogo, dal luogo della Non-presenza al luogo della Presenza? Certamente no, proprio perché il chiamare presentativo non “sottrae alla lontananza” il chiamato, bensì, al contrario, è precisamente questo cenno di chiamata a consentirne il permanere nel Lontano.
Dobbiamo dunque intendere la chiamata come una “duplicazione” del chiamato, che per una parte si porta nella presenza e per un’altra permane nella lontananza? Egualmente no, poiché se è la presentazione a mantenere nella Lontananza il chiamato, senza essa, o ante essa, il chiamato non potrebbe essere nel Distante: ciò che già e da sempre è presso qualcosa, non abbisogna di alcuna azione per permanervi.
Se, quindi, è la chiamata alla presenza che mantiene nel Lontano il chiamato, il chiamato non può essere già presente presso la Non-presenza come e giacché presenza, e la chiamata non può essere una con-duzione dall’Ab-senza alla Presenza. Inoltre, il per-manere qui non può non avere un significato differente dall’assenza di cambiamento, dalla continuità, dalla stasi, giacché è in conseguenza di un’azione, di un evento, che detto peculiare permanere si realizza e concreta, si fa a punto presenza e atto.
Ebbene, se il chiamare presentifica, fa essere presente – cioè semplicemente fa essere – il chiamato, conferendogli dimora presso la Lontananza, allora il chiamato non può essere presso la Non-presenza, ante la chiamata, se non come nulla. Ma essere come nulla significa non-essere e non-essere affatto alcunché. Allo stesso modo, se è la presentazione a consentire il restare presso la Lontananza di ciò che è condotto alla presenza, allora il permanere principia precisamente dalla chiamata: se e fintantoché qualcosa è chiamato alla presenza, esso può stare presso la Lontananza, può a punto permanere in essa.
E, pertanto: il chiamato non-era presso l’Ab-senza-di-Presenza, poiché qui non vi è presente (Enérgeia) alcun chiamato o chiamabile (Dýnamis). Il chiamato va presso l’Ab-senza-di-Presenza, egualmente presso la Lontananza-in-sé, e vi permane, in seguito alla chiamata presso la Presenza: entificare o attuare, presenziare o dimostrare (Deίknum), non altro epperò significa se non porre presenza nella presenza-della-Lontananza, ovverosia incontraddittorietà nella contraddittorietà-della-Contraddizione, parimenti positività nella positività-del-Negativo.
Solo parlando le cose sono, e sono giacché custodite nell’essere-del-Non-essere, dunque, in linguaggio heideggeriano, nella Temporalità dell’Essere, ebbene, egualmente, per noi, nella Storia del Destino o Sentiero del Giorno, nel disvolgersi ovvero diatetico e nell’escato-teleologico disvelarsi per deissi catafatica della Trascendentalità originaria o Tutto apofatico-prolettico, potenziale-sottrazionale, anticipazionale-ultimorizzontale della Presenza o dell’Atto, enantiodromicamente ordinantesi e da principio o costitutivamente (katà tò Chreṓn) strutturantesi secondo successione della partizione eidetico-distintiva (arithmòs kinéseos katà tò próteron kai ysteron) o tassonomia dell’inividuazione onto-identitaria (katà tḕn toũ Chrónou Táxis).
Il nominare non distribuisce nomi, non applica parole, bensì chiama entro la parola. Il nominare chiama. Il nominare avvicina ciò che chiama […]. Si tratta di un chiamare a sé, in virtù del quale, quel che ancora non era stato chiamato vien fatto vicino. Solo che questo chiamare a sé è appello nella lontananza, nella quale ciò che è chiamato permane come l’ancora assente. Chiamare è chiamare presso. E tuttavia, quel che è chiamato non resta sottratto alla lontananza, nella quale proprio quel cenno di chiamata di lontano fa che permanga. Il chiamare è sempre un chiamare presso e lontano; presso: alla presenza; lontano: all’assenza […]. Cosa chiama la prima strofa? Chiama cose, dice loro di venire. Dove? Non certo qui nel senso di farsi presenti fra ciò che è presente […]. Il luogo dell’arrivo, che è con-chiamato, nella chiamata, è una presenza serbata intatta nella sua natura di assenza. È questo il luogo in cui quel nominante chiamare dice alle cose di venire. Il chiamare è un invitare. È l’invito alle cose ad essere veramente tali per gli uomini.
Das Geviert
La caduta della neve porta gli uomini sotto il cielo che si oscura inoltrandosi nella notte. Il suonare della campana della sera li porta come mortali di fronte al Divino. Casa e tavola vincolano i mortali alla terra. Le cose che la poesia nomina, in tal modo chiamate, adunano presso di sé cielo e terra, i mortali e i divini. I quattro costituiscono, nel loro relazionarsi, un’unità originaria. Le cose trattengono presso di sé il quadrato dei quattro. In questo adunare e trattenere consiste l’esser cosa delle cose. L’unitario quadrato di cielo e terra, mortali e divini, immanente all’essenza delle cose in quanto cose, noi lo chiamiamo: il mondo. La poesia, nominando le cose, le chiama in tale loro essenza. Queste, nel loro essere e operare come cose, dispiegano il mondo […]. Le cose visitano di volta in volta i mortali sempre e solo insieme col mondo. La prima strofa parla dell’atto che dice alle cose di venire.
Se e solo fintantoché il linguaggio parla, le cose nominate possono con-chiamare alla presenza – ovvero, ancora, all’essere e all’atto – il Tutto-delle-cose, ossia il Mondo, ebbene la co-implicazione del Ni-ente e dell’Essere, del pari l’essere-del-Ni-ente, o piuttosto, ancora in linguaggio heideggeriano, l’Essere, che il filosofo, da un certo punto del proprio interrogare dell’Essere (Phainómenon, Anwesenheit), chiamerà Geviert, la Quadratura o il Quadrato dei quattro: Götter und Sterbliche, Himmel und Erde. Ad-unare e trattenere qui hanno, infatti, il medesimo senso del per-manere già incontrato: non già, ante il con-venire alla presenza delle cose nominate, i Quattro dimoravano presso unità, non già il Mondo stava fermo (nella presenza), come se, senza il sopraggiungere alla presenza delle cose chiamate dal linguaggio, i Quattro potessero in qualche modo disperdersi e dileguare da quella fermezza e da quell’unità (= da quella presenza) in cui già si trovavano, dimodoché l’evento del con-venire alla presenza delle cose avesse il compito di mantenere la Quadratura, ovvero il Mondo, nel proprio status – già in essere – di fermezza e unità, come se, altrimenti a dirsi, il Mondo e i Quattro del Mondo fossero e fermi e uniti, ma costantemente sotto la minaccia della molteplicità e della concussione, e le cose, evocate dal linguaggio alla presenza, giungessero in qualche modo a salvarli, consentendo loro di rimanere ciò che – già e da sempre – sono (Phýsis aeì sōizoménēs).
No, la Quadratura (il Mondo) non può essere se non e una e ferma. La Quadratura (il Mondo), non può essere, ossia è nulla (nel senso del nihil absolutum) se le cose non sono: se e solo fintantoché le cose sono, il mondo è.
Come il chiamare, che nomina le cose, chiama presso e rimanda lontano, così il dire, che nomina il mondo, è invito a questo a farsi vicino e, al tempo stesso, lontano. Esso affida il mondo alle cose e insieme accoglie e custodisce le cose nello splendore del mondo. Il mondo concede alle cose la loro essenza. Le cose fanno essere il mondo. Il mondo consente le cose.
Il chiamare, nominando le cose, le conduce alla presenza, immettendole nella Lontananza. Allo stesso modo, il dire che nomina il mondo, lo rap-presenta, ma non, come detto, ri-portandolo presso la presenza dalla lontananza in cui remoto era relitto, bensì proprio scagliandolo nel Distante.
Ovvero, solo dimorando presso il Ni-ente – tanto originario quanto trascendentalmente estremo il tutto-dell’ente-sopraggiuntente pre-avvolgente e sempre nella propria principiale escatia o Discostamento inseitale –, cose e mondo, nella loro co-implicazione necessaria, possono essere, solo dimorando nel Lontano possono farsi presenti.
Perché, invece, cose e mondo non possono essere intese come già e sempre dimoranti presso la Remotezza (= il Ni-ente) per semplicemente passare (Ubergang, Epamphoterizein) al Vicino (= all’Essere) nel tempo dell’e-vocazione della chiamata che nomina? Poiché dimorare presso il Ni-ente-della-dimorabilità significa non essere affatto alcunché, poiché, così pensato, il passaggio dal Nulla all’Essere (dal Remoto al Vicino, dalla Potenza all’Atto) pre-suppone il già esser-ci del transitante, il suo già essere ovvero qualcosa, ebbene il già essere questi una determinatezza (haecceitas), un’identità, (o, con Heidegger, il suo già essere appropriato [Eignen] a sé), un’individualità semplicemente abbisognante della proprietà della sostanza, dell’atto, della vicinanza.
No, la chiamata conferisce fondamento, atto e presenza, e alle cose del mondo e al mondo che contiene le cose solo poiché e solo fintantoché le conduce e pertiene presso l’essere-del-Niente, la vicinanza del Remoto, l’attualità del Possibile, e non dal Nulla assoluto all’Essere-dell’ente. Ciò che, nonpertanto, occorre ora portare alla preclarità della presenza, è che cosa significhi essere-presso-il-Ni-ente, essere-presente-nella-Lontanza o, parimenti, quale co-implicazione immorsi il Nulla assoluto, l’essere-del-Ni-ente e l’Essere-degli-enti-in-totalità.
Das Zwischen und der Unter-Schied: il Fra-mezzo e la Dia-ferenza
Mondo e cose non sono infatti realtà che stiano l’una accanto all’altra; essi si compenetrano vicendevolmente. Compenetrandosi i Due passano attraverso una linea mediana. In questa si costituisce la loro unità. Per tale unità sono intimi. La linea mediana è l’intimità. Per indicare tale linea la lingua tedesca usa il termine das Zwischen (il fra, il framezzo). La lingua latina dice: inter. All’inter latino corrisponde il tedesco unter. L’intimità di mondo e cosa non è fusione. L’intimità di mondo e cosa regna soltanto dove mondo e cosa nettamente si distinguono e restano distinti. Nella linea che è a mezzo dei due, nel framezzo di mondo e cosa, nel loro inter, in questo unter, domina lo stacco. L’intimità di mondo e cosa è nello stacco (Schied) del framezzo, è nella dif-ferenza (Unter-Schied).
L’Essere e gli essenti, il Tutto e le determinazioni del Tutto, sono fintantoché – al contempo – e si compenetrano vicendevolmente, intimamente, ossia sono condotti nell’unità-dei-due, e si dis-tinguono, nettamente, ovvero in essa dif-ferenza o diadità sono pertenuti. Pertanto, mondo e cose del mondo, per essere, debbono, da un lato, con-vergere presso quell’unità che è comune a entrambi, che con entrambi stringe relazione e che tutti e due con-rela e mantiene nell’unità cor-rensponsiva col proprio disporsi coalescente tra l’uno e l’altro, dall’altro, di-vergere l’uno dalle altre. Ebbene, quest’Uno con-relativo dei due deve avere sia qualcosa che lo accomuna a entrambi (Mondo [A] = X; X = Cose del mondo [B]), per potersi disporre quale fondamento della loro unione o intimità, sia qualcosa che lo differenzia da entrambi (A ≠ X; X ≠ B), per potersi disporre quale fondamento della loro differenza o estraneità, diversità o distanza. Quest’Uno, ulteriormente, deve dunque sia farsi “cosa del mondo” (en tô Kósmo), altrimenti non potrebbe essere-nel-mondo e correlare e mondo e cose, sia essere diverso e dal mondo e da ogni cosa del mondo (ouk ek toû Kósmou), ebbene deve essere cosa nel mondo, essente nell’Essere, come l’Altro da ogni cosa del mondo e dal Mondo stesso (Das Ganz-Anderes).
Questo essere come l’Altro da tutto e dal Tutto compatto stesso deuteriore (Émpleón [estin] Eóntos, Én, Synechés, Á-pauston, A-kínēton, An-ólethron) noi lo chiamiamo l’essere-della-Dif-ferenza, l’esserci ossia come il Non-essere-ente-alcuno, neppure come l’Essere-dell’ente-in-totalità (Pãn [estin] Omoĩon, Ólon); quest’Enadità-in-se-stessa-Divisa (Én-Dia-Phéron-Eautõ) o contro-se-stessa immanentemente rivolta (Én-Stasiázon-Pròs-Eautò), questa Relazione immediata altresì o Mediazione assoluta tra Essere-e-Nulla, noi l’appelliamo Soglia, Limes, Diácrisis, Partizione originaria (Ur-teilung).
La Dif-ferenza, di cui si parla, esiste solo come quest’una. È unica. La Dif-ferenza regge – non però con essa identificandosi – quella linea mediana, nel moto e nella relazione alla quale e grazie alla quale mondo e cose trovano la loro unità […]. La Dif-ferenza porta il mondo al suo essere mondo, porta le cose al loro essere cose. Portandoli a compimento, li porta uno verso l’altro. La composizione operata dalla Dif-ferenza non è qualcosa che avvenga in un secondo momento, quasi la Dif-ferenza sopraggiungesse recando una linea mediana e con questa congiungesse mondo e cose. La Dif-ferenza, in quanto linea mediana, media il realizzarsi del mondo e delle cose nella loro propria essenza, cioè stabilisce il loro essere l’uno per l’altro, di questo fondando e compiendo l’unità.
La Dif-ferenza fa essere – e le cose del mondo, e il mondo delle cose – giacché porta a compimento, ossia compone i differenti portandoli uno-verso-l’altro: far essere significa dunque distinguere, ovvero conferire quell’identità contraddistintiva esclusivamente in grazia della quale ogni cosa può essere ed essere sé se e solo fintantoché non è l’unità-del-non-sé, la propria alterità egualmente o contraddittorietà (contro-)coalita o (enantio-)adunata esattamente dalla posizione dell’identità distintiva o unitaria del sé, dell’ecceità sua.
La Dif-ferenza assoluta (Pólemos) è l’Unità originaria del mondo e delle cose del mondo, ossia è l’autentico fondamento comune (Hypo-keiménon) tanto del molteplice – ulteriore –, quanto del Tutto-del-molteplice – deuteriore.
La Differenza tra mondo e cosa fa che le cose emergano come quelle che generano il mondo, fa che il mondo emerga come quello che consente le cose. La Dif-ferenza non è né distinzione né relazione. La Dif-ferenza è semmai la dimensione di mondo e cose. Ma in questo caso “dimensione” non significa una regione a sé stante, dove questo o quello può prendere dimora. La Dif-ferenza è la dimensione, in quanto misura nella sua interezza, facendolo essere nella sua propria essenza, lo spazio di mondo e cosa. Il suo instaurante misurare dischiude, evocandolo all’essere, il vincolo di distacco e di indissolubilità tra mondo e cosa. Tale evocante dischiudere è il modo secondo il quale qui la Dif-ferenza misura nella loro interezza l’uno e l’altra. La Dif-ferenza, come linea mediana, di mondo e cose, rappresenta, generandola, la misura in cui mondo e cosa realizzano la loro essenza. Nel nominare, che chiama cosa e mondo, quel che è propriamente nominato è la Dif-ferenza.
Ossia il Ni-ente, l’essere-del-Ni-ente, quale sfondo – dia-fano/apo-fatico (Keraunós) – dell’Essere, dell’Essere-dell’ente.
Nella prima strofa l’invito è rivolto alle cose che, in quanto se stesse, generano il mondo. Nella seconda l’invito è rivolto al mondo che, in quanto se stesso, consente le cose. Nella terza l’invito è alla linea framezzo mondo e cosa: a ciò che fonda e compie l’intimità.
Gli essenti, giacché se stessi, generano l’Essere-degli-essenti. L’Essere-degli-essenti, consente agli essenti di essere. L’essere-del-Ni-ente, la Storia della Dia-ferenza (l’entificazione o impressione di incontraddittorietà progressiva al contraddittorio della Prolessi archea o Contraddittorietà autoctica, egualmente, nel nostro dire), originariamente fonda e porta a compimento e l’Essere-degli-essenti, conseguentemente, e tutti gli essenti, ulteriormente e infine, secondo necessità.
La Soglia e il Dolore
La soglia è l’impalcatura che regge il complesso della porta. Essa costituisce il punto nel quale i Due, l’esterno e l’interno, trapassano l’uno nell’altro. La soglia regge il framezzo. Alla sua fidatezza si adatta ciò che nel framezzo entra ed esce. La fidatezza di tale framezzo deve essere ferma e uguale in ogni direzione. Il potere di reggere e comporre del framezzo esige qualcosa che duri, e pertanto qualcosa di solido e valido. La soglia, come quella che regge il framezzo, è dura, perché il dolore l’ha pietrificata. Ma il dolore che si è fatto pietra, non si è solidificato nella soglia, per irrigidirsi in essa. Il dolore permane nella soglia come dolore. Ma che è il dolore? Il dolore spezza. È lo spezzamento. Ma esso non schianta in schegge dirompenti in tutte le direzioni. Il dolore, sì, spezza, divide, però in modo che anche insieme tutto attira a sé, raccoglie in sé. Il suo spezzare, in quanto dividere che riunisce, è al tempo stesso quel trascinare, teso in opposte direzioni, che diversifica e congiunge ciò che nello stacco è tenuto distinto. Il dolore è ciò che congiunge nello spezzamento che divide e aduna. Il dolore è la connessura dello strappo. Questa è la soglia. La soglia regge il framezzo, il punto in cui i Due si staccano e s’incontrano. Il dolore salda lo spezzamento della Dif-ferenza. Il dolore è la Dif-ferenza stessa […]. L’intimità della Dif-ferenza di mondo e cosa – questo sarebbe dunque il dolore? Certamente […]. Il dolore ha fatto la soglia atta al reggere che le compete.
Questa nuova immagine del dolore che pietrifica la soglia, dello spezzamento che riusce e aduna nel dividere e nel distinguere, per quanto poeticamente eccelsa, concettualmente non si discosta da quanto sin qui posto: ciò che tutto con tutto congiunge e inserta (e anzitutto il Tutto con tutte le cose del Tutto) è la stessa Dia-lacerazione (assoluta o in se stessa) di tutto con tutto. Questo è l’Essere che fonda e l’Essere e gli enti, questo è il Dolore autentico del mondo e delle cose del mondo.
Là risplende in pura luce
Sopra la tavola pane e vino.
Dove splende la pura luce? Sulla soglia, nel dolore che fonda e compone. È la cesura della Dif-ferenza che fa risplendere la pura luce. Il suo congiungere illuminante de-cide quel rischiararsi del mondo, per il quale il mondo si fa mondo. La cesura della Dif-ferenza porta il mondo a quel realizzamento della sua essenza di mondo, che consente le cose. Schiarandosi così il mondo e giungendo esso al suo aureo splendore, anche pane e vino pervengono al loro splendore.
Il mondo si rischiara, consentendo alle cose del mondo, pane e vino, di apparire, alla luce del mondo, nella loro luce, ma la luce del mondo non è il chiarore originario, la “pura luce”. Essa è fatta risplendere dalla Dif-ferenza. Gli essenti hanno fondamento nell’Essere, ma l’Essere (degli essenti) non è l’Originario, bensì riceve esso stesso fondamento dall’essere-del-Ni-ente, nell’essere-del-Ni-ente prendendo sopraggiunta dimora, localizzazione ossia contro-mediata o deutero-dedotta dall’immediata auto-entificazione rifrattiva dell’Originario in-sé Ni-ente, Dolore, Dif-ferenza, Soglia, Fram-mezzo (Zwischen, ΔΙΆ), Contraddizione, Alterità.
L’originario chiamare, che si volge all’intimità di mondo e cosa e a questa dice di venire, è l’autentico chiamare. Questo chiamare è l’essenza del parlare. Nella parola della poesia è il parlare. Questo è il parlare del linguaggio. Il linguaggio parla. Parla dicendo a quel che chiama, cosa-mondo e mondo-cosa, di venire nel framezzo della Dif-ferenza. Ciò che in tal modo è chiamato, mentre è sollecitato a muovere dalla Dif-ferenza (presso cui dimora) per portarsi qui, è insieme affidato alla Dif-ferenza.
Ma dimorare (= essere) presso la Dif-ferenza non altro significa se non dimorare nella Storia dell’Essere, ossia nella storicizzazione (Geschehen) dell’essere-del-Non-essere, ebbene, e altrettalmente, nella Storia dell’Uomo (Mensch-Geschichte), per questo, ciò che è qui alla presenza portato dalla chiamata, affida contemporaneamente il chiamato alla Differenza, alla Lontananza, poiché non lo depone nell’Essere-dell’essente, bensì in quell’Essere autentico, immorsato nella sua stessa essenza en-dia-dica, che del Ni-ente autoctico e autoprincipiativo è la co-implicazione necessaria e co-originaria, in quell’Essere archeo altresì e abissale in cui il medesimo Essere-dell’essente diviene deuteriormente deposto trovando-vi la solo propria dimora.
La Dif-ferenza è la Chiamata dalla quale soltanto ogni chiamare è esso stesso chiamato, alla quale pertanto ogni possibile chiamare appartiene. La Chiamata della Dif-ferenza ha già sempre raccolto in sé ogni chiamare […]. Il chiamare che raccoglie in sé ogni possibile chiamare, la Chiamata, identificandosi con la quale la Dif-ferenza chiama mondo e cose, è il suono della quiete. Il linguaggio parla in quanto la chiamata della Dif-ferenza chiama mondo e cose alla semplicità della loro intimità. Il linguaggio parla in quanto suono della quiete. La quiete acquieta, portando mondo e cose alla loro essenza. Il fondare e comporre mondo e cosa nel modo dell’acquietamento è l’evento della Dif-ferenza. Il linguaggio, il suono della quiete, è, in quanto Dif-ferenza è come farsi evento. L’essere del linguaggio è l’e-venire della Dif-ferenza.
La Quiete, in sé, altrimenti a ostendersi il Medesimo già differentemente datosi, null’altro è se non il Ni-ente, e il Suono della Quiete, il Linguaggio, null’altro è se non l’essere-del-Ni-ente. Ogni umano dire, ovverosia ogni ente storico, non può che dunque risuonare entro questa Dia-lacerazione (Hiatus) originaria che tutto e avvolge e fonda.
Der Herr und der Hirt: l’Uomo e l’Essere
Il suono della quiete non è nulla di umano. Certo l’uomo è nella sua essenza parlante. Il termine “parlante” significa qui: che emerge ed è fatto se stesso dal parlare del linguaggio. In forza di tale e-venire, l’uomo, nell’atto che è dalla lingua portato a se stesso, alla sua propria essenza, continua ad appartenere all’essenza del linguaggio, al suono della quiete. Tale evento si realizza in quanto l’essenza del linguaggio, il suono della quiete, si avvale del parlare dei mortali per essere dai mortali percepita come appunto suono della quiete. Solo in quanto gli uomini rientrano nel dominio del suono della quiete, i mortali sono a loro modo capaci di un parlare attuantesi in suoni […]. Il parlare dei mortali ha il suo fondamento nel rapporto col parlare del linguaggio […]. Il modo con cui i mortali, quando la Dif-ferenza li chiama a sé, a loro volta parlano, è il cor-rispondere. Il parlare mortale presuppone l’ascolto della Chiamata, identificandosi con la quale la quiete della Dif-ferenza chiama mondo e cose nella cesura della sua semplicità. Ogni parola del parlare mortale parla sul fondamento di questo ascolto e solo come questo ascolto. I mortali parlano in quanto ascoltano. Essi prestano attenzione al richiamo della quiete della Dif-ferenza, anche quando non lo conoscono […]. Il linguaggio parla. Il suo parlare chiama la Dif-ferenza, la quale porta mondo e cose nella semplicità della loro intimità, consentendo loro di essere se stesse […]. L’uomo parla in quanto cor-risponde al linguaggio. Il cor-rispondere è ascoltare. L’ascoltare è possibile solo in quanto legato alla Chiamata della quiete da un vincolo di appartenenza.
Certo, l’uomo, per Heidegger, come è noto almeno a partire dalla Lettera sull’Umanismo del 1947, “non è il padrone dell’ente”, e l’Essere non è nella piena disponibilità utilizzante dell’uomo come lo è qualsivoglia semplice presenza: “il suono della quiete non è nulla di umano”, pertanto. Ma neppure l’uomo – l’Esserci ovvero quell’ente che è quest’esistenza sempre nostra – è, in essenza, una semplice presenza utilizzabile (Mensch ist das transcendens schlechthin), giacché è pur egli “il pastore dell’Essere” – ossia, come già a quest’altezza sappiamo, dell’Essere –, colui epperò a cui l’Essere stesso demanda e affida la salvaguardia e la custodia della propria Verità (pertanto del proprio gregge [tà ónta, tà pánta] dispiegantesi per ordinamento d’ecceità nel Tempo dell’Essere, ovvero nell’orizzonte di impressione d’incontraddittorietà per successione elenctica del tutto dell’affermazione o entelechia della contraddizione alla sive della Contraddizione originaria), attraverso il “suo” pensiero, egualmente attraverso il “suo” linguaggio, ove il genitivo (suo = dell’essere), è a un tempo sia oggettivo che soggettivo: il pensiero è pensiero dell’Essere poiché gli appartiene; il pensiero è pensiero dell’Essere poiché – anzitutto o presuntivamente – lo pensa.
Ecco dunque che tra Uomo ed Essere, tra Uomo e Linguaggio, si instaura – e da sempre –, come qui in principio indicato, bicondizionalità: l’uomo, consentaneamente con quanto posto e da Aristotele e da Humboldt, è essenzialmente ente di pensiero e parola, ma è tale giacché e solo poiché con-risponde a un parlare più originario del proprio, ossia al parlare del Linguaggio stesso. Solo in quando gettato nella disponibilità originaria dell’Essere, di questo Essere, all’uomo possono venire incontro gli enti (utilizzabili e intra-mondani). Nondimeno, questo stesso Linguaggio, la sua essenza, ossia il Suono-della-Quiete (l’Essere-del-Non-Essere) “si avvale” dell’uomo per “essere percepito”, per di-venire condotto a destinazione completa, a estremo adempimento.
Non ha alcuna importanza proporre una nuova concezione del linguaggio. Quel che solo conta è imparare a dimorare nel parlare del linguaggio. Perché ciò sia possibile, è necessario un continuo esame di se stessi per vedere se e fino a che punto siamo capaci di un autentico cor-rispondere: di prevenire la Chiamata permanendo nel suo dominio.
Il compito (die Aufgabe) dell’uomo pertanto, per Heidegger, in definitiva, consiste nell’insistere presso l’ascolto della chiamata, dimorando nel dominio del parlare del Linguaggio, ossia, egualmente, nel persistere presso il pensiero dell’Essere.
Ciò che rimane purtuttavia sullo sfondo nel discorso heideggeriano (sul Linguaggio come sull’Essere), è precisamente il fondamento di necessità di quell’avvalersi dell’uomo, di cui il Linguaggio ha esigenza, per essere percepito, egualmente per essere, ossia, ancora portandoci nella co-implicazione di esistenza umana (Dasein) ed Essere, il ruolo che l’Uomo ha nella Seinsgeschichte.
In questa prolusione al Ni-ente autentico, preferiamo lasciare che sia il discorso heideggeriano a emergere, trattenendo il nostro sullo sfondo. Ci limitiamo nonpertanto, in clausola, ad accennare, a mo’ di epiclesi, quanto segue: se l’Essere è autenticamente concepito come essere-del-Ni-ente, tale Ni-ente, per esserci, ossia per farsi evento, deve necessariamente attraversare tutta la vicenda del proprio Dolore, tutta epperò la teoria della propria Dia-lacerazione particolarizzantesi, deve ovvero realizzare e concretare, attuare ed entificare, la Storia completa altresì della propria contraddittorietà o negazione (dunque della propria attualità e medesimezza, positività e coerenza, presenza e identità, egualmente sotto differenti categorie inquadrando il sempre Medesimo), disvolgendo completamente la successione o l’ordinamento del suono della Quiete.
L’uomo, pertanto, è l’agente del Dolore, il suo pastore (der Hirt), si magis placet: ogni sua azione, ogni suo pensiero, ogni sua parola, e anzitutto ogni sua parola poetica, ossia creatrice, incide la Quiete, egualmente imprime concretezza allo stare in principio presso prolettica concretezza del Negativo, così consentendogli in ultimo di essere Non-essere compiutamente o in pienezza d’essere (Entelécheia).
Ma questo Non-essere è l’a-bisso stesso dell’Uomo, di cui egli – e solo egli – è padrone (der Herr), e l’essere-del-Non-essere è la sua stessa – e solo sua – Storia, il solo e sempre proprio E-vento trascendentale e terribile (Tremendum), inaudito (Deinós), maliardo (Fascinans) e meraviglioso (Thaumásios). Con-stituisce infatti, in ultimo, e viepiù determina (Bestimmung) o conduce a destinazione il Destino stesso dell’Uomo (*Klèwos *Ndhgwitom, Geviert, Ólympos Éschatos, Kléos Ouranòn ikánei, Héros-Theós), l’affidare e da principio l’Uomo – categoriale (Olympikoí, Göttern, Athánatoi) – all’uomo – individuale (Chthónioi, Sterblichen, Thetoí).
[1] Edizione italiana: Il linguaggio, in, In cammino verso il Linguaggio, a cura di Alberto Caracciolo, Ugo Mursia Editore, 1973.